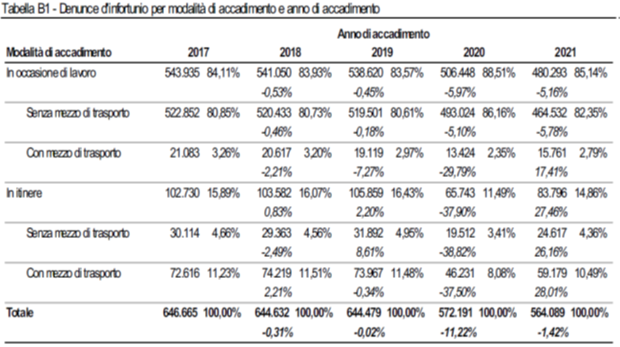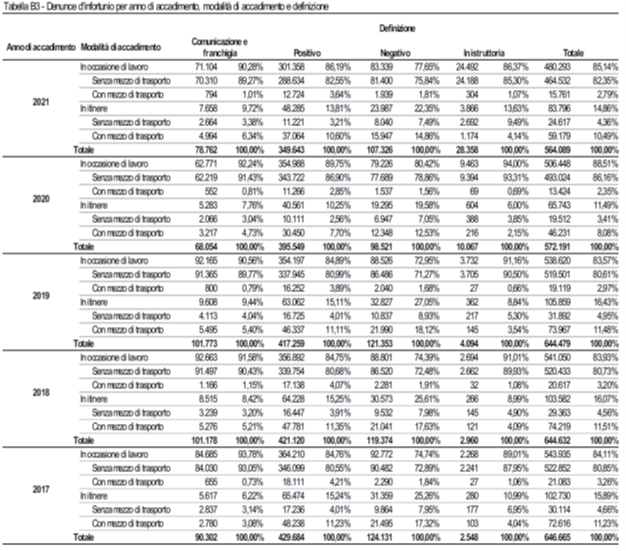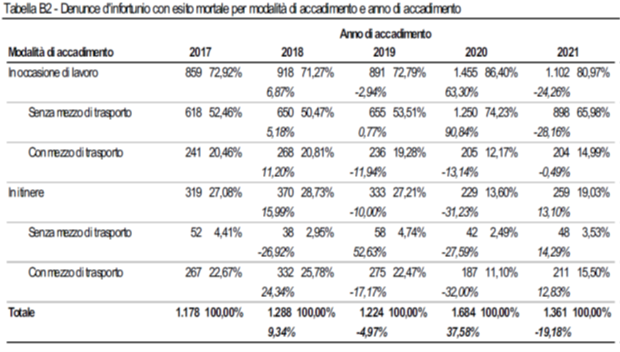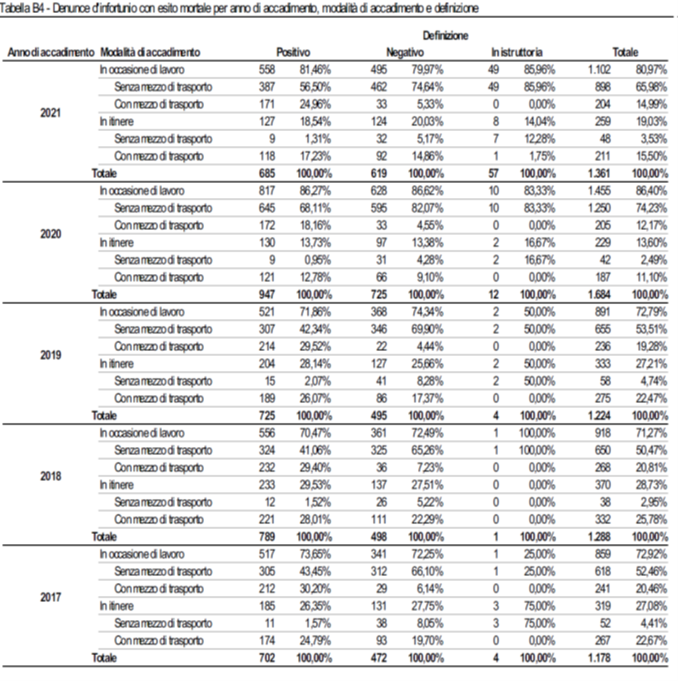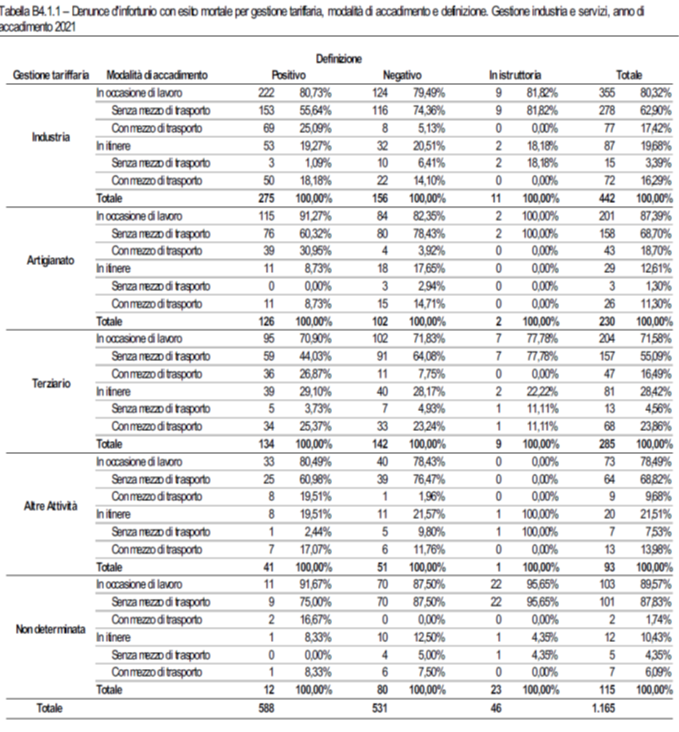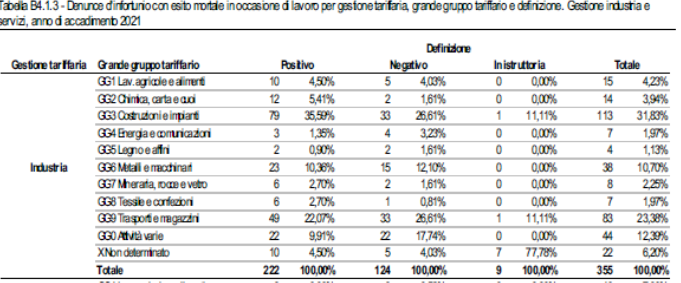Sommario
Le regole sulla sicurezza sul lavoro – mirate a proteggere il lavoratore nella concretezza dell’atto lavorativo - seguono le particolarità delle lavorazioni e delle modalità organizzative. Per questo motivo, il Dlgs 81/2008 distingue, ad esempio, tra lavoro subordinato, collaborazione e lavoro autonomo; tra lavoro in azienda e a domicilio e telelavoro; tra lavoro diretto e distacco o somministrazione; etc. Applicare l'applicazione integrale della disciplina della subordinazione è ontologicamente incompatibile con fattispecie differenti. Tra gli elementi che rilevano maggiormente, ci sono le limitazioni o l’assenza del potere organizzativo, gestionale e di vigilanza da parte del datore di lavoro. Un tema, questo, che avvince tutte le forme di lavoro nelle quali viene meno il tradizionale concetto di subordinazione e dove l’autonoma determinazione del lavoro assume un ruolo determinante. Ne sia esempio il lavoro dei riders (che, al di là della formale subordinazione, oggettivamente svolgono un lavoro esterno all’azienda ed ai luoghi sui quali il datore di lavoro può e deve esercitare il proprio potere organizzativo, gestionale e di controllo) o il lavoro agile (dove la legge espressamente esclude l’esistenza di un luogo e di una postazione di lavoro). Lo scritto si sofferma sulle argomentazioni di una recente sentenza cautelare del Tribunale di Palermo per evidenziare sia le incongruenze cui può portare l’estensione delle regole di sicurezza ad una forma di lavoro peculiare come quella dei cd riders sia la grave indeterminatezza che accompagna tutta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (nel rinvio al generico art. 2087 cc e nella individuazione specifica degli obblighi cautelari da rispettare), in violazione dei principi costituzionali che devono assistere e condizionare il diritto penale e dei limiti posti in campo civile in tema di applicazione analogica della legge in malam partem (applicando al lavoratore autonomo o parasubordinato le regole del lavoro dipendente).
Premessa
Il caso regolato dalla sentenza in commento è quello di un ciclofattorino che assumeva di essere “sottoposto, nello svolgimento della prestazione lavorativa, a condizioni di stress fisico derivanti dagli effetti del clima e in particolare dei raggi solari, che gli procuravano, durante le consegne tra le ore 12,00 e le ore 16,00, una condizione di spossatezza e grave disidratazione”.
In via d’urgenza, il Tribunale ha condannato “la società convenuta a consegnare al ricorrente, per la stagione estiva e dunque sino alla data del 23 settembre 2022, un contenitore termico contenente acqua potabile in misura pari al fabbisogno medio giornaliero, nonché integratori di sali minerali, nella medesima misura succitata, e una adeguata protezione solare”.
Per la verità, lo stesso giudice riconosce che è stata la società convenuta, nell’informativa in materia di sicurezza, “a identificare e a riconoscere, quale rischio specifico per il rider, il microclima, individuando fra le correlate Misure Preventive e Protettive adottare nella stagione estiva, l’introduzione di liquidi (non alcolici) e integratori salini e indicando quale misura atta tutelare la sicurezza del rider in caso di temperature più alte del normale, l’utilizzo della protezione solare”.
Quindi il datore di lavoro aveva correttamente valutato le misure di sicurezza da adottare, evidentemente poi non aveva concretamente assolto all’obbligo che egli stesso aveva individuato nel processo di “autonormazione” che caratterizza la valutazione dei rischi.
L’elemento di interesse, quindi, non è tanto l’adempimento o meno da parte del datore di lavoro, ma è quello della ricostruzione giuridica attraverso la quale il giudice individua la fonte normativa degli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza in questa fattispecie, e che porta, in sostanza, alla impropria equiparazione, ai fini delle misure di sicurezza, del collaboratore e del lavoratore autonomo al lavoratore subordinato, in deroga alla puntuale disciplina recata per entrambi i casi dal Dlgs 81/2008.
Nella sentenza si rinuncia, infatti, a qualificare la fattispecie concreta sottoposta per individuare le misure di sicurezza e si perviene alla conclusione della applicazione di tutti gli obblighi del Dlgs 81/2008, quale che sia la configurazione del rapporto di lavoro (collaborazione o lavoro autonomo), in quanto si applica l’art. 2087 cc (non direttamente il Dlgs 81/2008) in caso di collaborazione o la norma dell’art. 47septies del Dlgs 81/2015 (che richiama espressamente il Dlgs 81/2008), in caso di lavoro autonomo.
Osservazioni
Il punto di partenza dell’analisi sono gli articoli 2[1] e 47septies (comma 3[2]) del Dlgs 81/2015, che costituiscono il fondamento della disciplina in materia di sicurezza per quanto riguarda i cd riders, ossia lavoratori che eseguono prestazioni organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Nel primo caso, il rapporto giuridico che lega il rider alla piattaforma – ricorrendone le condizioni[3] - è qualificato come collaborazione, ma il legislatore esplicitamente ed in via generale (senza introdurre una specifica norma relativa alla sicurezza sul lavoro) dispone l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
La seconda ipotesi, alternativa e residuale[4] rispetto alla prima, è qualificata come lavoro autonomo e, tra le previsioni del capo V del D.Lgs. 81/2015, applicabili a questa fattispecie, è presente anche l’obbligo espresso di osservanza del Dlgs 81/2008.
A questo dato normativo si aggiunge una terza ipotesi, di natura sanzionatorio, legata alla esatta qualificazione del rapporto di lavoro, che emerge laddove l’accertamento concreto porti a ritenere l’esistenza non già di una collaborazione o di un rapporto di lavoro autonomo, ma di un rapporto di lavoro realmente subordinato.
In sintesi, quindi, sembrano potersi enucleare tre differenti ipotesi (fermo restando che la normativa del 2015 non ha introdotto un tertium genus nel rapporto di lavoro):
a. Se l’accertamento condotto in concreto, con prevalenza sulla forma contrattuale adottata, lascia emergere una vera e propria subordinazione, le regole, anche in tema di sicurezza sul lavoro, saranno quelle proprie della subordinazione (con le limitazioni sostanziali che si vedranno in seguito)
b. Se l’accertamento porta a confermare la natura della collaborazione, in presenza del triplice requisito previsto dalla normativa del 2015 ed in coerenza con la deroga introdotta dall’art. 2 del Dlgs 81/2015, si applicherà la disciplina del lavoro subordinato (anche in questo caso, per la sicurezza, occorrerà verificare il rapporto con le previsioni del Dlgs 81/2008, soprattutto in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa)
c. Se l‘accertamento porta a confermare la presenza di un rapporto di lavoro autonomo, si applicherà la disciplina residuale ed alternativa del capo V del Dlgs 81/2008 (ed anche in questo caso occorrerà, per la sicurezza, verificare quale sia la normativa applicabile).
Nel primo caso, un accertamento che portasse a negare sia la collaborazione che l’autonomia, affermando l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, dovrebbe condurre alla riconversione del rapporto di lavoro in sede ispettiva o giudiziale (con tutte le relative conseguenze) e, sul piano della sicurezza, dovrebbero in teoria affermarsi tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 per il lavoro subordinato.
È evidente, tuttavia, che le peculiarità dello svolgimento della prestazione lavorativa dell’organizzazione del datore di lavoro non possono non influire sulla individuazione selettiva degli obblighi e delle conseguenti responsabilità. Basti evidenziare che mancano sia un luogo di lavoro (non disponendo il datore di lavoro di alcun ambiente, né al chiuso né all’aperto) sia una organizzazione per la vigilanza da parte del datore di lavoro (dirigenti e preposti).
Potrebbero essere prese in considerazione misure quali, ad esempio, la formazione, la sorveglianza sanitaria, le dotazioni di sicurezza (DPI) o gli strumenti di lavoro (laddove forniti dal datore di lavoro).
Da questo punto di vista, quindi, la normativa appare carente di chiarezza e determinatezza, perché costringe l’interprete a selezionare gli obblighi (e le responsabilità) in mancanza di una fonte normativa che indica con chiarezza ed ex ante il confine tra lecito ed illecito, ricordando che la normativa in materia di sicurezza è interamente presidiata da sanzione penale.
Veniamo ora alle altre due fattispecie della coordinazione e dell’autonomia.
Partendo dalla duplice base normativa sopra richiamata (articoli 2 e 47septies, comma 3, del Dlgs 81/2015) e iniziando dalla collaborazione, l’espressa applicazione in deroga delle regole del lavoro subordinato è oggetto di una disposizione di disciplina e non di fattispecie[5], per cui la collaborazione resta tale anche se disciplinata con le regole del lavoro subordinato a maggior tutela del lavoratore (non si applica, in sostanza, alcuna riconversione del rapporto di lavoro).
Sul piano della sicurezza, dall’applicazione della legislazione sul rapporto di lavoro subordinato, il giudice deduce il riferimento non già al D.lgs. 81/2008 ma ai generali e generici principi contenuti nell’art. 2087 cc, in quanto “norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, imponendo all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti con l'adozione, fra l’altro, di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare il lavoratore dalla sua lesione nell'ambiente”.
Sembra, quindi, che il D.Lgs. 81/2008 non sia applicabile direttamente, poiché non contiene una puntuale disciplina relativa al lavoro su piattaforma, rendendo così necessario e possibile necessario ricorrere alla norma di chiusura (l’art. 2087 cc), che, appunto, entra in gioco in assenza di una disciplina specifica o di regole non aggiornate.
Probabilmente, il percorso argomentativo che porta a questa conclusione prende atto della difficoltà di regolare gli aspetti della sicurezza in un rapporto che si svolge concretamente (e legittimamente, altrimenti sarebbe stato riconvertito in rapporto di lavoro subordinato) con le modalità della collaborazione ma che deve essere disciplinato (in una logica latamente sanzionatoria) dalle regole del lavoro subordinato, nonostante il D.Lgs. 81/2008 contenga una specifica disciplina per la collaborazione legata alle particolari modalità con le quali viene seguita la prestazione.
In mancanza di un luogo di lavoro rientrante nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (art. 3, comma 7, Dlgs 81/2008), fare riferimento alla disciplina del D.Lgs. 81/2008 avrebbe condotto a non applicare alcuna misura di sicurezza. E, si badi bene, non si tratta di un vulnus di tutela ma di una scelta normativa che risponde ad una precisa ratio.
Secondo l’art. 3, comma 4, infatti, il D.Lgs. 8/2008 si applica infatti a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, ma resta “fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo”. E il successivo comma 7 prevede, opportunamente, che le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ai collaboratori “ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.
Le regole della sicurezza seguono infatti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (e le concrete modalità esecutive) in quanto ciascuna fattispecie ha delle caratteristiche fattuali ed organizzative della prestazione lavorativa che impongono di modulare le previsioni di legge, anche secondo il potere di organizzazione del datore di lavoro e l’aspetto essenziale della vigilanza sui comportamenti del lavoratore.
Esempi ne siano, per i profili d’interesse, gli artt. 3, comma 7 e 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, che condizionano l’applicazione delle regole al fatto che si sia in presenza di un luogo cdi lavoro che rientra nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, e 21, che prevede una ipotesi (per il lavoro autonomo) di autoprotezione.
Applicare la disciplina di sicurezza misurata sul lavoro subordinato e fondata su di una organizzazione tipica di tale rapporto (ad es., sul tema del luogo di lavoro e del potere di vigilanza) ad un lavoratore che svolge la prestazione all’esterno è infatti ontologicamente incongruente con la logica della normativa sulla sicurezza.
Rilievo, questo, fatto proprio dalla stessa giurisprudenza[6], laddove evidenzia che “non possono escludersi situazioni in cui l'applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell'ambito dell'art. 2094 cod. civ., ma si tratta di questione non rilevante nel caso sottoposto all'esame di questa Corte”.
La stessa perplessità è stata fatta propria dall’ispettorato nazionale del lavoro[7], il quale tuttavia, a fronte di una impropria estensione generalizzata di tutti gli obblighi di sicurezza del lavoro subordinato, ha tentato, con la stessa logica creativa della giurisprudenza, di selezionare il fascio degli obblighi del datore di lavoro della piattaforma tra quelli propri del rapporto di lavoro subordinato :
“In tali casi (prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali), l’accertamento della natura etero-organizzata della collaborazione comporterà l’estensione della disciplina in materia di salute e sicurezza del rapporto di lavoro subordinato con particolare riguardo ad alcuni profili, quali la formazione e l’informazione dei collaboratori, il controllo del committente sulle attrezzature di lavoro, la denuncia di infortunio, la sorveglianza sanitaria e la completezza del documento di valutazione dei rischi, oltre all’obbligo a carico del datore di lavoro di fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (cfr. Trib. Firenze decr. 1° aprile 2020 e Trib. Bologna decr. 14 aprile 2020). Risulta, a tale ultimo riguardo, decisivo che le specificità legate alle modalità esecutive delle prestazioni dei lavoratori etero-organizzati siano contemplate all’interno della valutazione dei rischi effettuata dal committente (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla necessità di inserire nella valutazione dei rischi l’utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature proprie o di propri mezzi di spostamento)”.
È evidente che la modalità della prestazione lavorativa del rider su piattaforma non contempla, in genere, l’esecuzione in locali del datore di lavoro, che potrebbero anche non esistere, ma si svolge interamente su strada e , come evidenzia la richiamata nota dell’INL, “la qualificazione giuridica del rapporto non è sempre dirimente per l’applicazione delle tutele prevenzionistiche che seguono invece criteri diversi, primo fra tutti quello della presenza del collaboratore in uno specifico contesto lavorativo”.
Mutuando la logica dell’art. 3 del Dlgs 81/2008, il legislatore – per lo specifico tema della sicurezza - avrebbe dovuto indicare espressamente gli obblighi che si applicano a questa fattispecie, ad esempio indicando selettivamente le misure necessarie, ad esempio quelle indicate nella nota sopra richiamata dell’Ispettorato nazionale del lavoro[8].
In mancanza di questa normativa, la sentenza parte dalla residuale genericità dei principi contenuti nell’art. 2087 cc per poi specificarli selettivamente, con l’individuazione e l’applicazione di tre puntuali misure (acqua potabile, integratori di sali minerali e protezione solare).
Il ruolo (impropriamente) creativo esercitato dal giudice avrebbe anche potuto spingersi fino ad individuare regole più stringenti: sospensione dell’attività nelle ore più calde, riduzione o riorganizzazione dei turni e dei ritmi di lavoro, dotazione di automezzi chiusi e dotati di aria condizionata, dotazione di abbigliamento adeguato, adozione di specifici modelli di casco, etc.
La scelta operata dal giudice porta a ritenere che le tre misure selettivamente individuate siano quelle che, “secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” mentre altre, anche più stringenti, non siano invece necessarie.
In realtà – ad ulteriore dimostrazione che non può essere l’interprete a definire ex post le puntuali misure da applicare ma che il compito di introdurre norme cautelari modali può settare solo al legislatore - , seguendo altra recente giurisprudenza[9] la presenza di norme cautelari aperte (es., art. 180 Dlgs 81/2008) determina l’individuazione ex post della regola corretta da parte dell’interprete: “in situazioni del genere, vanno previste ed applicate regole precauzionali capaci di prevenire la concretizzazione del rischio, evitando di sottoporre il lavoratore ad attività all'esterno faticose in ore calde, prevedendo pause di riposo frequenti, predisponendo ripari ombreggiati, oltre ad accorgimenti sul vestiario, nonché sulla alimentazione e idratazione”.
Secondo la sentenza “pur in presenza di una norma cautelare "aperta", nessun tipo di accorgimento era stato adottato per proteggere il lavoratore dal rischio di un danno alla salute come conseguenza di una prolungata esposizione al sole, in costanza di temperature assai elevate, durante lo svolgimento di mansioni lavorative pesanti e faticose”.
Per cui “appariva evidente il nesso di causalità con l'attività lavorativa che la vittima stava svolgendo, così come evidente l'esito del giudizio controfattuale che l'evento mortale non si sarebbe verificato se i datori di lavoro avessero adottato le precauzioni contro le influenze atmosferiche, anche sospendendo i lavori nelle ore più calde”.
Evidente l’incoerenza con i principi costituzionali di legalità e determinatezza, laddove il confine tra lecito ed illecito è individuato dall’interprete e non dal legislatore ex ante ed in modo determinato e tassativo attraverso l’individuazione di regole cautelari di natura necessariamente modale.
Per altro verso, va sottolineato che il datore di lavoro deve (e può) limitarsi a “consegnare” detti i presidi indicati nella sentenza del Tribunale, non potendo controllarne l’uso effettivo, dal momento che il lavoro si svolge in luoghi non soggetti alla sua disponibilità ed al suo potere di vigilanza ed intervento.
Va, poi, rilevato che il giudice ha individuato e prescritto misure di tipo non organizzativo ma che incidono o possono incidere sulla salute del lavoratore, senza alcun supporto di natura sanitaria: da un lato, limitandosi ad indicare dispositivi (acqua e integratori minerali) e quantità generici (“fabbisogno medio giornaliero”) e, dall’altro, indicando una generica protezione solare (non valutando né la tipologia, né la gradazione né eventuali allergie del lavoratore).
Vi è poi una ulteriore riflessione. I riders, in quanto collaboratori, svolgono normalmente la propria attività per più datori di lavoro (in regime di pluricommittenza), ciascuno dei quali dovrebbe erogare la stessa formazione (con evidenti inutili duplicazioni) o mettere disposizione due litri d’acqua e quantità di sali minerali o creme solari.
Quanto sopra vale laddove il rapporto venga (previamente) qualificato come collaborazione su piattaforma, alla quale vengono applicate le regole del lavoro subordinato, secondo il giudice per il tramite dell’art. 2087 cc.
La soluzione giurisprudenziale adottata su questo versante conferma la denunciata genericità della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e l’inammissibile ruolo creativo della giurisprudenza.
Laddove si volessero implicitamente richiamati gli obblighi del Dlgs 81/2008 (che il giudice invece esclude), dovrebbe concludersi necessariamente per l’applicazione delle specifiche regole della sicurezza espressamente previste dal medesimo Dlgs 81/2008 per la fattispecie della collaborazione, in quanto le regole indicate in tema di sicurezza per questa ipotesi specifica sono dettate in ragione delle peculiari modalità di svolgimento della prestazione, al di fuori dei locali aziendali.
Se, invece, si ritenesse di applicare le regole del lavoro subordinato anche in tema di sicurezza, la torsione selettiva delle regole ontologicamente applicabili e coerenti con la concreta modalità lavorativa deve essere sottratta all’interprete e rimessa al legislatore (posta anche la portata penale delle prescrizioni in materia di sicurezza).
Deve, infatti, ritenersi scontato che non è possibile né coerente individuare ed applicare regole che non si confrontano con la concreta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (si tratta, in altre parole, di quelle disposizioni ontologicamente incompatibili con la fattispecie concreta della prestazione lavorativa nelle modalità della collaborazione richiamate dalla giurisprudenza[10]).
La conclusione, inoltre, genera evidenti dubbi di coerenza, laddove la medesima prestazione sia resa, con identiche modalità, in applicazione di un contratto collettivo che regoli il trattamento economico e normativo: laddove il trattamento normativo convenuto fosse quello della collaborazione previsto dal Dlgs 81/2008, esso, riportando il sistema a coerenza, modificherebbe notevolmente, anche in pejus, le regole in tema di salute e sicurezza.
Passando ora all’ipotesi alternativa e residuale del lavoro autonomo, con un passaggio che genera evidenti perplessità e che dimostra ancora una volta l’assoluta indeterminatezza della fonte normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il giudice evidenzia che “anche a voler prescindere dalla applicazione nella specie dell’art. 2 Dlgs 81/2015, con tutte le conseguenze sopra viste, trova sicura applicazione nel caso in esame anche l’art. 47septies del citato decreto”.
Il giudice sembra, quindi, concludere che, se il rapporto di lavoro non rientra nella fattispecie della collaborazione ma viene qualificato come autonomo, trova applicazione direttamente il Dlgs 81/2008, “che deve intendersi richiamato per intero sulla scorta di un’interpretazione coerente con la ratio della norma”.
In primo luogo, va osservato che la norma dell’art.47septies si riferisce esclusivamente al lavoro autonomo, per cui il rinvio espresso e generico al D.Lgs. 81/2008 vale solo per questa forma contrattuale e non si applica alla collaborazione, tanto è vero che il giudice stesso ha dovuto fare riferimento all’art. 2087 cc. Quindi, si può prescindere dall’applicazione dell’art. 2 solamente se il rapporto di lavoro si configura come autonomo, segnando così due ipotesi differenti che non possono/devono essere confuse.
In secondo luogo, anche il rinvio generale al D.Lgs. 81/2008 genera il problema della individuazione delle misure che sono coerenti con la modalità esecutive del lavoro autonomo.
Va quindi ripetuto, oltre a quanto già detto per la collaborazione, che il D.Lgs. 81/2008 disciplina specificamente e razionalmente diverse ipotesi (collaborazione, lavoro autonomo, distacco, lavoro domestico, lavoro a distanza, etc.), per cui ogni regolazione deve essere individuata secondo la logica delle diverse discipline contenute nel Dlgs 81/2008 (in particolare, articoli 3 e 21[11]) che distinguono obblighi e responsabilità in funzione del dato sostanziale.
È evidente, infatti, almeno sul piano della sicurezza sul lavoro, l’incoerenza della affermazione secondo la quale ad un rapporto di lavoro dichiaratamente autonomo (nemmeno equiparato a quello subordinato) si applica la disciplina del lavoro subordinato, ossia la parte del D.Lgs. 81/2008 diversa dall’art. 21.
Va poi rilevato che, poiché in base all’art. 3, co. 4 e 11, d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 c.c. si applicano (esclusivamente) le disposizioni di cui all’art. 21, l’estensione al committente degli obblighi previsti per il datore di lavoro comporterebbe una applicazione analogica in malam partem, in contrasto con l’art. 25 Cost. e con l’art. 14, disp. prel.[12]
Quindi la conferma della natura autonoma del rapporto di lavoro, la peculiarità di svolgimento della prestazione ed il rinvio ad una fonte normativa che disciplina espressamente anche l’ipotesi del lavoro autonomo distinguendola da quella del lavoro subordinato, impediscono di ritenere che il rinvio possa intendersi fatto all’intero Dlgs 81/2008[13] e impongono invece di valorizzare la esplicita disciplina contenuta nell’art. 21 del Dlgs 81/2008 (pur con la specificazione che le misure previste in quella norma sono, in questa ipotesi, a carico della piattaforma e non del lavoratore autonomo).
Conclusione
La fase esclusivamente cautelare non giustifica l’affermazione di questa lettura della normativa in materia di salute e sicurezza e la soluzione adottata (in mancanza di una chiara base normativa selettiva degli obblighi) conferma la necessità di una rivisitazione complessiva dell’impostazione della normativa in questa delicata materia.
Va, infatti, ricordato che l’intera normativa in materia di salute e sicurezza è presidiata dal diritto penale, nel quale vigono il principio di determinatezza (che attribuisce al solo legislatore del compito di tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e irrilevanti) e il principio di legalità (che evita che il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito, posto che l’ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo).
L’assenza di previsioni (nel caso della collaborazione) o il generico rinvio al D.Lgs. 81/2008 (per il lavoro autonomo) non mettono in condizione né il lavoratore di conoscere le tutele cui ha diritto né il datore di lavoro di conoscere il confine tra il lecito e l’illecito (conoscendo puntualmente gli obblighi sanzionati), e rendono così impropriamente necessario l’intervento dell’interprete che non può che illegittimamente ricorrere all’opera selettiva ex post o a norme di chiusura (incostituzionali, proprio perché finalizzate a coprire il deficit di legalità rispetto ai parametri costituzionali sopra richiamati).
La sede civile e cautelare non impegnano queste ultime riflessioni, ma la ricostruzione operata nella sentenza “a prescindere” è dimostrazione ulteriore che l’unica tecnica normativa ed interpretativa legittima in materia di sicurezza (e nel diritto penale) è quella della rispettosa dei principi di legalità e determinatezza, da conseguire con la puntuale indicazione delle regole cautelari modali differenziate a seconda delle differenti fattispecie in esame (un chiaro esempio è contenuto proprio negli articoli 3 e 21 del D.Lgs. 81/2008).
In sede civile, va richiamato il principio secondo il quale l’estensione al committente (che vale sia per la collaborazione che per il lavoro autonomo) degli obblighi previsti per il datore di lavoro comporterebbe una applicazione analogica in malam partem, in contrasto con l’art. 25 Cost. e con l’art. 14, disp. prel.
 Trib. Palermo ord. 3 agosto 2022.pdf|Visualizza dettagli
Trib. Palermo ord. 3 agosto 2022.pdf|Visualizza dettagli
[1] “1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
[2] “3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
[3] Personalità, continuità, etero-organizzazione
[4] Con maggior precisione, la circolare n. 17/2020 del Ministero del lavoro chiarisce che “quello dell'articolo 47-bis, in forza dell'espressa clausola di salvezza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, è disegnato come residuale in rapporto a tale ultima previsione, e che questa, quindi, costituisce l'ipotesi attrattiva prevalente di disciplina dell'attività dei riders”.
[5] Così, Cass., sent. n. 1663/2020
[6] V. Cass., sent. n. 1663/2020
[8] Si verifica, in questo caso, lo stesso problema che si riscontra con riferimento al lavoro agile, dove il generico rinvio al D.Lgs. 81/2008 non consente di individuare la specifica disciplina applicabile ad una fattispecie che si svolge al di fuori dei locali del datore di lavoro, in assenza di orario di lavoro e di luogo di lavoro.
[9] Cass., sent. n. 30897/2022
[10] Come evidenziato da Cass., sent. n. 1663/2020
[11] L’art. 26 sull’appalto risulta inapplicabile ai rider in quanto presupposto affinché possano sorgere gli obblighi di protezione ivi previsti a carico del committente è che questi abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui opera il lavoratore, circostanza quest’ultima da escludersi nel caso di specie.
[12] Così, D. Draetta, Il lavoro autonomo dei riders ai tempi del Covid-19, in RIDL, 3/2020, 473 ss
[13] Contra, Trib. Firenze, ord. 886/2020

 Decreto 15 settembre 2022.pdf
Decreto 15 settembre 2022.pdf